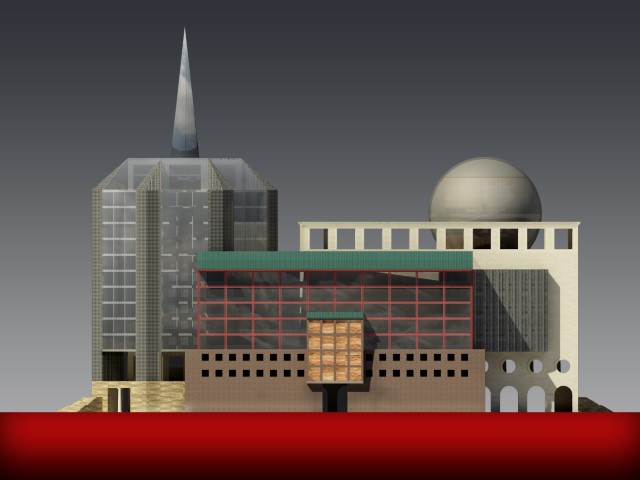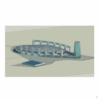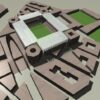Prosegue dall’Articolo precedente:PROCESSI E METODI DELL’ARCHITETTURA – I. Ars, Techne kai Polis
Con questo articolo si intende affrontare la relazione fra tecnica ed architettura che, con il rapido sviluppo della tecnologia di produzione dell’architettura, sia a livello del progetto che a livello della costruzione e della gestione, rischia di incidere profondamente sul ruolo antropologico dell’architettura stessa.
Per agevolarne la lettura è stato suddiviso in tre parti, come un “feuilleton”, l’ottocentesco romanzo d’appendice, o come le attuali serie TV, sceneggiate in funzione di più sostenibili livelli di attenzione, creando partecipazione emotiva nel fruitore e mantenendo l’esito sospeso. Ovviamente i nostri obiettivi sono altri.
Le tre parti sono distinte ed autonome ma integrate completamente dal punto di vista contenutistico e, al fine di una comprensione efficace dell’articolo, è auspicabile che vengano lette integralmente e secondo la successione proposta.
I. Ars, Techne kai Polis
II. Tecnica dell’Architettura e tecnologia
III. Tecnologia avanzata e stabilità dell’architettura
II. Tecnica dell’Architettura e tecnologia
Nonostante quanto rilevato nell’articolo precedente, nella concezione culturale contemporanea l’architettura viene fatta passare come branca particolare della “tecnica”, motivo per il quale sovente il suo insegnamento viene relegato ai “Politecnici” assieme a tutte le inquantificabili ed inqualificabili accezioni dell’ingegneria, che ormai raggiungono ed investono qualsiasi forma di sapere contemporaneo, anche non rapportabile in alcun modo all’attività del costruire. In realtà l’architettura non è neanche una branca del sapere o, meglio, non lo è mai stata fino ad ora: nelle culture storiche, di tutti i tempi e di tutte le aree geografiche, l’architettura si costituisce come “sapere parallelo”, rispetto a quello teso alla conoscenza ed alla risoluzione dei problemi del “mondo” e rispetto a quello proiettato verso la conoscenza e la risoluzione dei problemi dell’entità “uomo”
La tecnica in architettura non è mai riconducibile a sé stessa, piuttosto è strumento di relazione tra i concetti vitruviani di fabrica et ratiocinatio (3). Invece il discorso sulla tecnica, la “tecnologia”, esprimendo in quanto lógos condizioni che “manifestandosi si impongono”, si sviluppa come branca autonoma del sapere, solo con l’avvento della civiltà industriale ed è riconducibile più propriamente allo studio dei processi e dei metodi per la produzione di oggetti, beni e servizi, indistinti rispetto alle caratteristiche peculiari del luogo ed alle esigenze di orientazione dell’uomo: dall’auto veloce, al computer, alla medicina, fino alla cibernetica. Elementi tecnici, questi, orientati al miglioramento della condizione umana che, tuttavia, sono riferibili al mutevole divenire di “Krónos”, e non hanno il “tempo” di incidere sull’essenza della convivenza umana, sulla saggezza che esprime i valori “platonici” della polis concernenti il pudore e la giustizia, tradizionalmente riconducibili ad ogni specifica cultura.
L’Architettura è estranea a tutto ciò, piuttosto, con il suo carattere riferibile all’immutabile persistenza di “Aión”, incarna la “filotechnia” e la “filosofia”, nelle loro accezioni più ampie e nelle loro specificità più marcate.
La tecnica entra nella dimensione più vasta dell’architettura non come tecno-logia ma piuttosto come tecno-sofia, nella sua accezione platonica di sapienza tecnica. La tecno-logia, in quanto discorso sulla tecnica, come è propriamente deducibile dall’etimologia greca, lascia che la tecnica manifestandosi s’imponga, con la propria autonomia disciplinare; al contrario la tecno-sofia, in quanto sapienza tecnica antropologica, saggezza connessa alla profondità della storia e della tradizione è tutta orientata nella risoluzione tecnica di problemi esistenziali e culturali. Paradigmatica in tal senso può essere assunta l’intera opera di Filippo Brunelleschi, dove la grande padronanza tecnica è sempre orientata verso la risoluzione dei problemi esistenziali e culturali, anche imponendo a questi carattere assolutamente innovativo. Nonostante l’apparente complessità delle argomentazioni trattate, questi aspetti investono anche e soprattutto l’architettura tradizionale e la cultura spontanea del costruire, nelle innumerevoli accezioni presenti nell’ambito delle differenti culture storiche. Manifestazioni della cultura difficilmente riscontrabili in epoca di globalizzazione ma che gli architetti hanno il ruolo ed il dovere di rintracciare, riscoprire e reinserire nel contesto culturale contemporaneo.
Il ruolo dell’architetto del terzo millennio non può essere fuorviante rispetto alle riflessioni che Eupalino esterna, attraverso il racconto di Fedro, nell’opera di Valéry, la quale contiene l’essenza del rapporto fra l’uomo e lo spirito dell’uomo: fra la tecnica e la giustizia ed il pudore, come elementi sottesi alla produzione dell’architettura (4).
La possibilità di produrre Architettura anche nel prossimo futuro non potrà esimersi dal ricondursi alla “filotechnia” e alla “filosofia”, aspetti inscindibili della civiltà, che costituiscono l’essenza di tutte le culture storiche ed allo stesso tempo ne individuano anche le specificità e ne caratterizzano la produzione delle opere (5). In questo senso la produzione architettonica del terzo millennio dovrà mantenere in un delicato equilibrio questi aspetti culturali antropologici, operando un costante livello di identificazione fra teoria e prassi, fra la necessità di produrre per la sussistenza del corpo e quella di far cultura per gratificare lo spirito, allo stesso modo di come la produzione mitica arcaica era anche la poetica mitica arcaica, infatti nella lingua greca antica poesia e produzione si esprimono entrambe con “póiesis”, confermando in questa identità semantica sia la consapevolezza della responsabilità insita nell’atto stesso della produzione, che trasformandole impone alle cose un senso loro estraneo, sia il senso e lo spirito elevato della vita, dove non sono distinti gli atti della produzione per la sussistenza materiale rispetto a quelli della produzione poetica per la sussistenza dello spirito. In tutto questo si trovano anche forti identità con il linguaggio e la cultura orientale, che sottolineano il carattere universale e “globale” della suddetta struttura antropologica.
Tali aspetti, che non possono essere disgiunti in nessuna opera architettonica, hanno una valenza importante per il carattere globale della nostra cultura ma si concretizzano esclusivamente attraverso le tecniche e la cultura specifica di ciascun “luogo” particolare. Costruire una casa o, meglio, produrre un’opera di architettura, comporta un atto di creazione, un atto di emulazione del “grande architetto dell’universo”. Nella cultura storica tradizionale, protesa a riscattare l’eterna condanna inflitta all’agricoltore e faber Caino, è particolarmente evidente la sacralità implicita nell’atto del costruire, dove “filotecnia” e “filosofia” si fondono armonizzandosi in un unico atto “poetico”. Tale atto esprime la tecnica e la sapienza che comportano sia la consapevolezza della responsabilità implicita nella trasformazione della realtà naturale, vitale anche per la sopravvivenza della specie, sia il senso e lo spirito elevato della vita, la percezione dei quali è indispensabile per la riproduzione della specie.
(3) Il Tema fra del rapporto fra teoria e pratica è stato affrontato in termini essenziali ma estremamente chiari in VITRUVIO POLLIO, De Architectura, Trad. It. di Silvio Ferri, VITRUVIO POLLIONE, Architettura, Rizzoli, Milano 2002, pag. 89
(4) PAUL VALÉRY, Eupalinos ou l’Architecte, Trad. It. Di R. Contu, Eupalino o l’Architetto, Edizioni Biblioteca dell’Immagine, Pordenone 1997, pag. 18
(5) per quel che concerne il rapporto con le categorie antropologiche dell’artificio, del sapere, quindi della produzione delle opere, la póiesis, vedi il mio saggio Architettura Mantica in MASSIMO FAGIOLI – STEFANO MARTINELLI, Luoghi, Tempo e fondazione dell’architettura, All’insegna del Giglio, Firenze 1996, pag. 51 e pag. 60.
Segue nel prossimo Articolo: III. Tecnologia avanzata e stabilità dell’Architettura


L’articolo è stato pubblicato integralmente sulla “Rubrica Alesia” del quotidiano Primo Piano Molise distribuito con il Messaggero