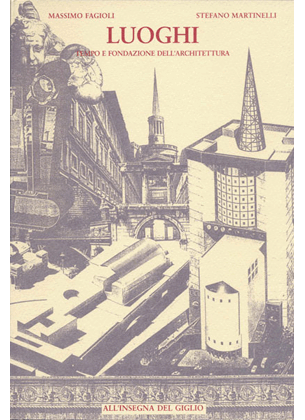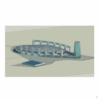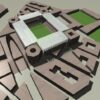Con questo articolo si intende affrontare la relazione fra tecnica ed architettura che, con il rapido sviluppo della tecnologia di produzione dell’architettura, sia a livello del progetto che a livello della costruzione e della gestione, rischia di incidere profondamente sul ruolo antropologico dell’architettura stessa.
Per agevolarne la lettura è stato suddiviso in tre parti, come un “feuilleton”, l’ottocentesco romanzo d’appendice, o come le attuali serie TV, sceneggiate in funzione di più sostenibili livelli di attenzione, creando partecipazione emotiva nel fruitore e mantenendo l’esito sospeso. Ovviamente i nostri obiettivi sono altri.
Le tre parti sono distinte ed autonome ma integrate completamente dal punto di vista contenutistico e, al fine di una comprensione efficace dell’articolo, è auspicabile che vengano lette integralmente e secondo la successione proposta.
I. Ars, Techne kai Polis
II. Tecnica dell’Architettura e tecnologia
III. Tecnologia avanzata e stabilità dell’architettura
I. Ars, Techne kai Polis
“Tempo vi fu in cui esistevano gli dèi, ma non le stirpi mortali. … gli dèi … nell’atto in cui stavano per trarre alla luce quelle stirpi ordinarono a Prometeo e a Epimeteo di distribuire a ciascuno facoltà naturali in modo conveniente. Epimeteo chiede a Prometeo che spetti a lui la cura della distribuzione … Solo che Epimeteo, al quale mancava compiuta sapienza, aveva consumato, senza accorgersene, tutte le facoltà naturali in favore degli esseri privi di ragione: gli rimaneva ancora da dotare il genere umano e non sapeva cosa fare per trarsi d’imbarazzo. Prometeo allora, … per la salvezza dell’uomo, ruba a Efesto e ad Atena il sapere tecnico (techno-sofia), insieme con il fuoco … e ne fece dono all’uomo.”
Questo passo tratto dal “Protagora” di Platone evidenzia come Prometeo pensi di mettere in condizione l’uomo di sopravvivere nell’ambiente naturale facendogli acquisire l’arte e la tecnica. Ma dallo scorrere della narrazione si evince come lo stesso sapere tecnico esercitato individualmente non consentiva agli uomini di superare le avversità insite nell’ambiente naturale dato che gli uomini, privi della scienza politica, di cui era depositario solo Zeus, non erano capaci di aggregarsi e di fondare città, la “polis”. Allora, come recita il testo platoniano, Zeus, temendo per la nostra specie, inviò Ermes perché portasse agli uomini il pudore e la giustizia, affinché servissero da ordinamento della città e da vincoli costituenti unità di amicizia. Chiede Ermes a Zeus in qual modo debba dare agli uomini il pudore e la giustizia: “A tutti, rispose Zeus, e che tutti ne abbiano parte: le città non potrebbero esistere se solo pochi possedessero pudore e giustizia, come avviene per le altre arti”(1).
Il mito raccontato da Protagora nella versione riscontrabile nell’omonima opera di Platone ribadisce con sostanziali analogie la vicenda di Caino ed Abele, rintracciabile all’interno dell’Antico Testamento, a conferma di come alcune strutture antropologiche riferibili al mito, alla religione ed alla cosmogonia, hanno carattere universale, essendo riscontrabili in culture e civiltà di luoghi e di tempi differenti, spesso lontani fra loro. Come avviene nella conclusione della narrazione di Protagora anche Caino, sulla cui radice si innesta l’etimologia della parola araba “qayn”, fabbro, quindi depositario del sapere tecnico, per riscattare la sua condanna al supplizio dell’inanità fonda la prima città, Enoch(2), e così facendo recupera la “stabilitas” originaria. Il termine “stabilitas” non esprime solamente il concetto di “stanzialità” e permanenza in luogo, ma racchiude in sé anche quei contenuti riferibili alla stabilità delle relazioni civili necessarie all’ordinamento delle città, paragonabili a “il pudore e la giustizia” platonici.
Dall’apparato mitologico riscontrabile in tutte le culture storiche, si può verificare come sia inscindibile il rapporto fra la tecnica, indispensabile a coltivare le pulsioni concernenti la sopravvivenza dell’uomo, e la saggezza, che si manifesta con la giustizia ed il pudore degli uomini nella loro interazione col mondo. Rapporto, questo, che si può esercitare esclusivamente nella forma della convivenza civile, nella città, così come nel borgo, nel villaggio o nel casolare patriarcale, e che si manifesta per mezzo della costruzione delle strutture architettoniche a rappresentare tali forme di convivenza civile.
In questo senso l’architettura, che è espressione fondamentale e autonoma del sapere antropico ed allo stesso tempo della convivenza civile, incarna gli aspetti connessi con la perizia tecnica, non potendo tuttavia prescindere da quanto concerne la saggezza, condizioni queste che sono generalmente riscontrabili nelle differenti culture storiche, anche di diverse aree geografiche.
(1) Trad. It. di Francesco Adorno, PLATONE, Protagora, Laterza, Bari 1996, pagg 26-31.
(2) Antico Testamento, Genesi 4,17 in La Sacra Bibbia a cura Conferenza Episcopale Italiana 1974, Edizioni Paoline, Roma 1980, pag. 4.
-Segue nel prossimo Articolo: II. Tecnica e tecnologia dell’Architettura-


L’articolo è stato integralmente pubblicato sulla “Rubrica Alesia” del quotidiano Primo Piano Molise distribuito con il Messaggero